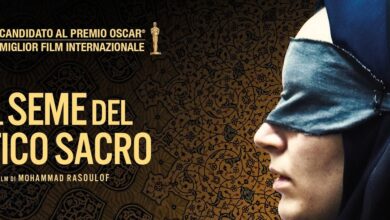La distanza tra terra e cielo
Al cinema pretendiamo l’emozione. Intesa in tutte le sue possibili declinazioni, dalla risata al pianto all’angoscia, annoverando come emotive anche le spinte, le dialettiche, le provocazioni che ci spingono alla riflessione razionale sulla proposta filmica. Tale premessa mi permette di leggere l’ultima fatica di Costa-Gavras come un film che forse non emoziona, intendendo con questo il coinvolgimento che dovrebbe portare lo spettatore ad assumere parte della vicenda su di sé attraverso uno o più personaggi, ma che sicuramente offre diversi spunti di riflessione, fosse anche solo per i temi trattati. Potremmo definire Amen. un film che vuole assolutamente informare il proprio pubblico di una zona della nostra storia recente. Perché se è vero che abbiamo il dovere di non dimenticare per riuscire ad osservare meglio il presente ed avere lungimiranza verso il futuro, è altresì vero che il quadro storico dovrebbe essere il più possibile completo, privo di censure ipocrite e/o strumentali ad uno o più poteri.
Amen. torna ancora una volta indietro nel tempo fino a raggiungere il periodo buio delle persecuzioni naziste, spostando questa volta la focale verso il “poco detto”, il “raccontato male”, il “sì è vero, ma bisognerebbe approfondire, tenendo conto di vari fattori”, ovvero la posizione della Santa Sede e Pio XII al cospetto della sistematica deportazione degli ebrei e del conseguente sterminio. Diciamo subito che il clamore causato dalla censura sul manifesto con quella croce rossa a forma di svastica (o svastica che diventa una croce) da parte, pare, del distributore, puzza di espediente per spostare il discorso su fattori secondari anziché sui contenuti. Del resto non se ne è parlato tanto da sospettare una manovra pubblicitaria. Non è certamente il Costa-Gavras di Missing (e forse Kassowitz non sarà Lemmon), ma la capacità di scuotere la materia storica contemporanea, quando rischia di ristagnare pericolosamente, è immutata.
Il film si sviluppa su un doppio binario: da una parte la cronaca di eventi terribili, dalla pianificazione scientifica del genocidio all’eliminazione vera e propria, fino alla “neutralità” di Roma; dall’altra il calvario di due uomini che si adoperano perché il progetto delle SS trovi delle resistenze. Il meccanismo narrativo è piuttosto semplice e lineare. Kurt Gerstein, ufficiale SS esperto in chimica (realmente esistito), comprende con orrore che il suo lavoro è parte di un progetto che intende eliminare in massa gli ebrei. Da buon cristiano tenta di informare i vertici della Chiesa tedesca. Solo il giovane gesuita Riccardo Fontana (personaggio inventato), vicino alla corte papale, si mobilita attivamente per chiedere a Pio XII di prendere posizione a difesa della vita. Da quel momento in poi la sceneggiatura si muove alternativamente sui tentativi dei due uomini, impegnati ognuno nel proprio “ambiente natio” ad impedire l’attuazione del piano nazista, che al contrario sembra procedere ad una velocità direttamente proporzionale all’ambiguo atteggiamento del Vaticano.
L’urgenza di mostrare i fatti, con un’aderenza storica che vorrebbe fugare ogni dubbio (il regista si rifà ad un testo teatrale di Rolf Hochhuth, Il vicario), sacrifica l’approfondimento psicologico dei personaggi. L’obiezione di coscienza, ad esempio, componente importante in entrambi, viene asservita all’economia del racconto e pagata nel finale, quando la triste fine del prete e del soldato non scalfiscono davvero, rimanendo secondarie rispetto al disgusto provato di fronte all’ipocrisia.
Buoni e cattivi
Costa-Gavras sceglie così di affidare la cifra drammatica del suo film alla concatenazione degli eventi in maniera tale da rendere impossibile qualsiasi fuga di informazione dalla sala buia, in un rapporto causa-effetto che rende palese la definizione di buoni e cattivi. Il tutto scandito dal ritmo incessante dell’alternarsi di treni di deportati, vuoti e pieni, come fosse il tic-tac di un ordigno ad orologeria. Quel treno che avevamo lasciato in Train de vie simbolo di un viaggio fantastico verso la libertà e la misericordia divina, ma che adesso ritorna ad essere puro segno di morte, violento nonostante (forse per questo) il regista scelga di lasciarla sempre fuori campo. Scelta condivisibile dal momento che lo spettatore può ben vantare un immaginario così ampio da poter ritrovare con facilità le immagini mancanti, chiamate da quello scorrere continuo di vagoni, ma anche dalla invadente presenza dell’acido prussico, le confezioni di Zyklon B, da cui il gas letale.
Tanto Costa-Gavras risulta didascalico nel chiedere allo spettatore di non dubitare mai degli assunti storici, quando sentiamo dire che Hitler è “scomodo” ma tutto sommato “ha sconfitto i comunisti”, o quando il montaggio contrappone la desolazione dei campi allo sfarzo vaticano; e tanto sorprendono alcune soluzioni registiche, come nel momento in cui Gerstein scopre che lo Zyklon è strumento di sterminio: gli effetti visibili (solo per le SS) attraverso uno spioncino, ci vengono suggeriti dal movimento lieve di una parete metallica, quasi fosse il respiro affannoso di un uomo morente, un uomo-edificio. Viene in mente un discorso “vecchio” di quarant’anni relativo alla moralità delle immagini.
Ad ogni modo colpisce il ritratto di un clero segnato dalla lontananza dai precetti evangelici, impegnato a salvaguardare l’istituzione, a rimandare a Dio ciò che l’uomo rifugge per viltà, politicizzato e corruttibile, ipocrita e opportunista, capace di difendere i diritti di malati di mente e handicappati, condannati a epurazioni o ad un destino da cavie da laboratorio, fingendo poi l’inesistenza dei campi di sterminio. Amen. mette in scena una Chiesa che accetta di nascondere gli ebrei, se convertiti (“è un convertito?… manteniamo distanti le due sensibilità”), quasi che la vita di un cattolico valesse più di quella di un non cattolico.
La rinuncia alla vita
Soprattutto quando i tedeschi arrivano a Roma si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un patteggiamento tra corti principesche, come in un neomedioevo, dove, come ebbe a dire ottocento anni fa il sanguinario Innocenzo III dando ordine di sterminare i catari confusi con i cattolici, “Dio riconoscerà i suoi”. In questo quadro Riccardo più che un S. Francesco è l’immagine di un uomo che sceglie di condividere la condanna a morte emessa sugli ebrei senza pretendere di incarnarela Parola; non ripropone Cristo, ma incarna una umanità che rinuncia alla vita per incapacità di dare risposta ad una violenza inaudita. Anche quando la risposta potrebbe arrivare  semplicemente dalla pratica cristiana. Un SS carnefice che dichiara più volte di essere un po’ cattolico (“imboscato” alla fine proprio da un cardinale), dirà a Riccardo che “la vostra Chiesa ha mostrato in passato che la purificazione si può ottenere bruciando dei corpi”. Non solo riferimento ad inquisizione e crociate, ma anche un’associazione di idee aberrante, giustificata dalla follia visionaria di uomini con aspirazioni superomistiche, e dalla constatazione di come ogni struttura di potere saldi la propria posizione attraverso la sopraffazione.
semplicemente dalla pratica cristiana. Un SS carnefice che dichiara più volte di essere un po’ cattolico (“imboscato” alla fine proprio da un cardinale), dirà a Riccardo che “la vostra Chiesa ha mostrato in passato che la purificazione si può ottenere bruciando dei corpi”. Non solo riferimento ad inquisizione e crociate, ma anche un’associazione di idee aberrante, giustificata dalla follia visionaria di uomini con aspirazioni superomistiche, e dalla constatazione di come ogni struttura di potere saldi la propria posizione attraverso la sopraffazione.
Se di Gerstein Costa-Gavras ci lascia colpevolmente solo intuire la profondità del suo sconforto, il senso di colpa relativo alla sua posizione di SS, e di Riccardo pare trascurare la dialettica inevitabile tutta interiore tra utopia cristiana e realtà di fatto della Chiesa secolarizzata, descrivendo unicamente all’esterno questa componente nelle figure grottesche dei vescovi ci offre invece senza mezzi termini tutti i dati per decifrare i lati più oscuri dell’umanità. L’immanenza di qualsiasi forma di potere retto su rapporti gerarchici non può che fallire progetti trascendenti; e la misura di questo fallimento sta tutta nella distanza tra l’artefice uomo e la “lingua celeste”, soprattutto quando l’uomo afferma di parlare a nome di Dio.
Alessandro Leone
(Pubblicato sul n°18 della versione cartacea, marzo 2002)