Pensieri sulla critica d’arte – qualunque cosa si intenda con quest’ultimo termine, ad esempio oggetto frutto di una espressione artistica – sono di loro natura poco numerosi. Ci sarebbe da chiedersi se la questione non si situi in una tendenza psicologica a voler parlare poco del proprio lavoro, ma tenderei a pensare che la realtà dei fatti dipenda da qualcosa di più semplice, come il fatto di preferire fare critica che scrivere di critica (anche perché con la prima azione ci si può mangiare, mentre con la seconda no, tranne nel campo del pubblico di nicchia, in una a volte grottesca orgia endogama). Eppure, a volte riflettere della e sulla critica – le due preposizioni in realtà non presentano differenze se non di vezzo stilistico – diventa un atto dovuto nel momento in cui ci si chieda effettivamente a cosa serva. Una domanda, quest’ultima, che andrebbe fatta sia dagli addetti ai lavori, sia dal pubblico (a volte non pagante) che si appropria per qualche minuto dell’analisi, profonda o superficiale che sia, di un prodotto artistico.
È probabile, allora, che il concetto di critica che qui si propone acquisti una sua importanza con lo sviluppo psicologico della persona, sviluppo che la porterebbe a dire che non tutto ciò che ci viene offerto ha motivo di essere consumato. Il pubblico che sia entrato nell’età adulta, superato quindi il limite che si attesta tra i diciotto e i venti anni, dovrebbe iniziare a fare i conti con una serie di elementi che tolgono spazio a quello che sarebbe un uso (e abuso) spesso sconsiderato del tempo a disposizione; se i ragazzi e i bambini hanno un rapporto con l’aspetto temporale abbastanza elastico e sf(il)acciato, non lo stesso si può dire di chi invece abbia iniziato a dover contabilizzare le ore libere in relazione alla necessità di soppesare il tempo del dovere e dell’obbligo – lo studio e il lavoro, principalmente – con quello dello svago. Eppure, la scelta di dedicare il proprio tempo a un prodotto anziché a un altro deve dipendere anche da un memento mori che, in forma esplicita o implicita, ci mette davanti a un dato di fatto incontrovertibile: prima o poi si crepa.
Il fatto di non avere una vita che sfoci nel concetto di infinito immanente è quindi causa di una doppia presa di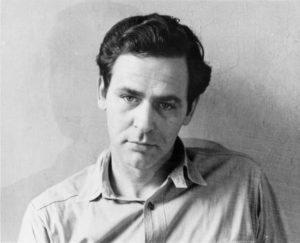 coscienza: da una parte non avremo mai tempo per vedere tutte le pellicole create nel mondo, dall’altra le ore che dedichiamo a un’opera non ci verranno mai restituite. Dalla conflagrazione di queste due epifanie ne fuoriesce una conclusione di cui non possiamo mettere in sordina la portata: avendo poco tempo a disposizione, il pubblico, nelle sue sfaccettature, cercherà di dedicarsi a quei prodotti che lo facciano star bene, qualunque cosa quest’ultimo concetto possa esprimere. Un dato di fatto forse abbastanza scontato, certo, ma che porta a manifestarsi una ulteriore epifania: nessuno può dire se una cosa valga il suo tempo se quella cosa non la sperimenta lui stesso. Il gatto si morde la coda: per non sprecare tempo dovrei indirizzarmi in maniera cieca sperando di non star gettando alle ortiche le mie ore, entrando così in un pantano dove è facile rimanere bloccati.
coscienza: da una parte non avremo mai tempo per vedere tutte le pellicole create nel mondo, dall’altra le ore che dedichiamo a un’opera non ci verranno mai restituite. Dalla conflagrazione di queste due epifanie ne fuoriesce una conclusione di cui non possiamo mettere in sordina la portata: avendo poco tempo a disposizione, il pubblico, nelle sue sfaccettature, cercherà di dedicarsi a quei prodotti che lo facciano star bene, qualunque cosa quest’ultimo concetto possa esprimere. Un dato di fatto forse abbastanza scontato, certo, ma che porta a manifestarsi una ulteriore epifania: nessuno può dire se una cosa valga il suo tempo se quella cosa non la sperimenta lui stesso. Il gatto si morde la coda: per non sprecare tempo dovrei indirizzarmi in maniera cieca sperando di non star gettando alle ortiche le mie ore, entrando così in un pantano dove è facile rimanere bloccati.
Il valore della critica, in questo contesto, arriva perciò ad assumere una carica di utilità sociale. Il critico non starebbe semplicemente dicendo se e perché un’opera abbia valore estetico, strutturale e narrativo, ma permetterebbe al pubblico di sapere previamente se quelle ore di cui dispone possano essere spese bene o male. Che il pubblico premi il lavoro del critico guardando o rifiutandosi di vedere un’opera è allora un problema secondario; ciò che rende necessario il lavoro di analizzare un film e di consigliarne o sconsigliarne la visione è un rendersi conto che il tempo a nostra disposizione è limitato e che quindi non va (non andrebbe) sprecato. A corollario di ciò, si andrebbe così a dire che la base su cui si fonda la critica non è tanto l’apprezzamento estetico (questo sarebbe un aspetto fondamentale, sì, ma in seconda battuta), quanto il riconoscimento del valore di un prodotto nell’ottica del consumo temporale.
 Non c’è però bisogno di scomodare teoriche visioni di semidivinità, che vedrebbero nella analisi dei film una specie di ecumenica azione di salvezza dell’uomo e del suo tempo. Il critico deve fare il suo lavoro in forma secca, asciutta, usando gli strumenti di cui è fornito (leggasi le nozioni e l’intuito), tenendo a mente che il suo dovere si riparte tra il dare una lettura corretta dell’oggetto in questione, come anche il tenere a mente il pubblico a cui viene a essere proposto. Ma è interessante notare che questa necessità di valutare sottintenda in forma più o meno ovvia il concetto di limitazione a cui tutti siamo legati e di cui non possiamo disfarci. La critica, allora, acquista una coscienza di sé più profonda, meno astrattamente estetica (che deriva in taluni casi in una inutilmente acquosa, come in certe letture di film che leggono molto più di quello che effettivamente ci viene dato), e nel suo rapporto dialogico con il contesto universale di cui fa parte (senza esserne elemento imprescindibile, giacché di arte si può anche non vivere) può aiutare gli spettatori a decidere di cosa fare di una parte – forse piccola – della propria vita.
Non c’è però bisogno di scomodare teoriche visioni di semidivinità, che vedrebbero nella analisi dei film una specie di ecumenica azione di salvezza dell’uomo e del suo tempo. Il critico deve fare il suo lavoro in forma secca, asciutta, usando gli strumenti di cui è fornito (leggasi le nozioni e l’intuito), tenendo a mente che il suo dovere si riparte tra il dare una lettura corretta dell’oggetto in questione, come anche il tenere a mente il pubblico a cui viene a essere proposto. Ma è interessante notare che questa necessità di valutare sottintenda in forma più o meno ovvia il concetto di limitazione a cui tutti siamo legati e di cui non possiamo disfarci. La critica, allora, acquista una coscienza di sé più profonda, meno astrattamente estetica (che deriva in taluni casi in una inutilmente acquosa, come in certe letture di film che leggono molto più di quello che effettivamente ci viene dato), e nel suo rapporto dialogico con il contesto universale di cui fa parte (senza esserne elemento imprescindibile, giacché di arte si può anche non vivere) può aiutare gli spettatori a decidere di cosa fare di una parte – forse piccola – della propria vita.
Guido Negretti

